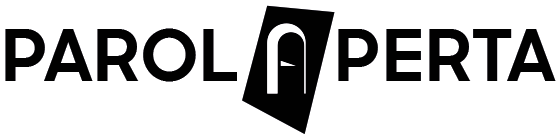Ogni volta che scendo dal treno e metto piede in questa stazione, in questa città, sento la mia pelle scrostarsi, sbucciarsi, e poi ricostituirsi poco a poco. Come si sbuccia una mela, solo che poi cerco di ricomporre la buccia.
Cambio pelle ogni volta che torno a casa, e ne ho una ancora diversa quando riparto.
A Lecce il sole è sempre più giallo che negli altri posti, si scioglie nel cielo, che è liquido e acceca. Quando piove l’umidità s’incastra nel mare, nei capelli e nelle case bianche. A Roma il sole non è mai troppo giallo e, quando piove, le pozzanghere sfumano subito.
Come potrei avere la stessa pelle in due posti così diversi?
Quando torno a casa faccio dieci passi indietro negli anni, indosso una pelle che ha ancora il profumo dello shampoo al cocco che usavo da bambina di ritorno dalla spiaggia; del dopobarba di papà, che ha il colore degli occhi di mia madre; e dei fiori rossi del vestito preferito di mia nonna. Con questa pelle me ne vado in giro per piazza Roma, per il lungomare di Porto Cesareo e gioco a cogliere dettagli sempre nuovi che incido su qualche lembo di pelle che spero di conservare. Registro le novità ma quando sono gli altri a raccontarmele m’incazzo di brutto, perché loro ci sono e io no. Me le incido ancora più a fondo le cose nuove, perché, nonostante sia stata io a decidere di andar via, provo la paura irrazionale di perdermi qualcosa di importante, di non essere più parte di quel lentissimo flusso che è la vita di un paese, di una panchina, di una fioriera o di un bar.
La paura che nessuno si ricorderà di me, che su quella panchina ho dato il mio primo bacio, che in quell’aiuola sono caduta mentre imparavo ad andare in bicicletta.
Ogni volta che torno a casa, alla fine, tra tutte le cose che mi appunto addosso per paura di dimenticarle, questa pelle si appesantisce così tanto che, non appena salgo sul treno per ritornare a Roma, inizio a non tollerarne il peso: questa pelle finisce per asfissiarmi, devo toglierla. Durante il viaggio sul Frecciarossa perdo le squame, mi sbuccio poco a poco, lascio in giro per la carrozza scaglie di me, di cose nuove che ho annotato e di cose vecchie che devo rammentare sempre. A metà del tragitto, più o meno verso Benevento, sono finalmente sgusciata via da quella pelle.
Il tempo di respirare un attimo, e poi di nuovo inizio a cucirmene addosso una nuova. Ha un colore meno deciso, è più leggera, perché ancora non ci ho inciso troppe cose da ricordare. Ci ho abbozzato dei nomi, naturalmente, dei posti, ma ancora è una pelle abbastanza anonima, da decidere, come un impermeabile trasparente.
Questo mi elettrizza, mi fa sentire piccola, alla scoperta del mondo, mi ricorda che sono quasi scappata dal mio paese perché mi ero convinta che non ci fosse più nulla da scoprire e non riuscivo più a sentirmi bambina.
Mi sento leggera.
Leggera, perché a volte, assoggettata dalla calca in metro, dalla folla in piazza di Spagna, mi sento davvero come un piccolo granello di mondo che esiste solo in quanto parte di quella folla, in quel dato momento. Posso sbagliare, inciampare, andare in giro in pantofole, ma resterò solo una testa tra le tante che affollano villa Borghese, come palline da biliardo. Eppure, mentre mi preparo a scendere dal treno, mi rendo conto che tanti piccoli lembi della vecchia pelle sono rimasti incastrati nella nuova, ma in questo nuovo contesto assumono fattezze diverse anche loro: quelle della nostalgia.
Nostalgia, senso di appartenenza tradito, voglia di evasione e speranza di ritorno allo stesso tempo, senso di colpa, malinconia; un gomitolo di cose a cui non riesco a dare un nome.
Prendo la valigia dalla cappelliera, la voce metallica degli altoparlanti ha annunciato la mia fermata: Roma Termini. Guardo le bucce di pelle che mi sono lasciata dietro lungo la carrozza, tra gli altri sedili: gli altri passeggeri, mi chiedo, possono vederle?
Ci sarà, forse, la scia di un’altra pelle frantumata, la pelle di qualcun altro che come me se n’è dovuta riarrangiare una? Mi guardo attorno. Certo che c’è un’altra scia, sono decine.
Penso che dev’essere bello riuscire a convivere sempre con la stessa pelle, senza fare la muta come le tartarughe, ma penso anche che gli esseri umani non ne siano capaci. Mi sono convinta che le persone, periodicamente, sguscino via dalla propria pelle e assumano nuove sembianze, senza accorgersene.
Io, per il momento, convivo con questa buccia che si scompone e ricompone come i lego, fragilissima come il guscio di un uovo e trasparente come un calice di vetro.