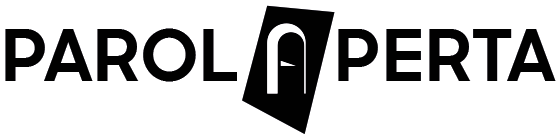Ho tra i tredici e i quattordici anni, siamo al massimo nel 2014.
Il rap in Italia è ancora una sub-cultura, non è ancora prospettabile alcun tipo di successo su scala nazionale, nonostante il tema oltreoceano fosse totalmente sdoganato.
È uscito da poco “Non siamo più quelli di Mi Fist”, opera tutt’ora ultima dei Club Dogo.
Il titolo dell’album è un messaggio chiaro: il rap si sta evolvendo, nelle sonorità, nelle tematiche, nei contenuti, nei mezzi e nelle forme.
E con lui si stava evolvendo -ed esautorando- quello che è stato e probabilmente resterà il trio più iconico ed importante del rap nostrano.
I Dogo lo urlano a gran voce: siamo cambiati, “Non siamo più quelli di Mi Fist” e tutti dovevamo -aggiungerei, fortunatamente- farcene una ragione.
Io però ho tra i tredici e i quattordici anni, i Dogo li conosco grazie a PES, più qualcosa di “Noi siamo il club”, penultimo album edito del trio.
Fantastico, non sono più quelli di Mi Fist.
Ma che cazzo è Mi Fist? Mi chiedo.
Vado su YouTube e inizio a recuperare tutta la discografia del Club.
“Chi ascolta per poco il Dogo dopo ha le orecchie sporche” dice Jake in D.O.G.O., e ha maledettamente ragione.
La narrativa, le metriche, i suoni.
Tanto crudi e violenti quanto profondi e viscerali, da sporcare l’anima e l’animo di chiunque ci entri in contatto.
Probabilmente nemmeno loro ai tempi sarebbero stati capaci anche solo di immaginare che tipo di istituzione sarebbero diventati.
D.O.G.O. è il secondo brano di “Penna Capitale”, l’album a cui sono probabilmente più affezionato.
Una Volta Sola, Falsi Leader, Briatori, La Notte Che Rovesciammo L’Ordine, Cani Sciolti 2006.
Un manifesto di quello che Jake, Guè, Don Joe e tutta la Dogo Gang -il collettivo nato dopo l’affermazione del Club, tra i cui Marracash- hanno saputo regalare all’hip hop italiano.
Brani politici, provocatori, aggressivi, contenutistici, colmi di storia di vita e di vite.
Ma se si ha l’accortezza di scorrere tutta la tracklist, si può avere la fortuna di inciampare in uno dei pezzi più toccanti e crudi mai concepiti dalle immense penne di Guè Pequeno e Jake La Furia.
No More Sorrow.
La prima canzone per cui ho pianto.
Non credo sia casuale che Guè inizi il brano con “Dicono che chi pensa soffre di più // quindi la lacrima è più densa”.
Si parla di dolore, della voglia di scacciarlo, dell’eterno conflitto tra l’essere e l’apparire, e di quegli infami compromessi che si creano per risolverlo.
“Superficialità e materialismo vogliono affogarmi
Le paure di non farcela puntano in faccia armi
Resto un altro peccatore, dipende chi fa le regole
Se non sono un bastardo per gli altri resterò un debole”
Il Guercio non si risparmia dal mettersi a nudo, dal chiedersi se quella vita di strada ostentata, se quella ricerca di essere “un bastardo” affinché gli altri non lo reputino un debole, sia quello di cui ha concretamente bisogno.
Ci racconta delle pressioni delle aspettative, di quella paura di non farcela che sembra essere un retaggio martoriante e al contempo di quanto sia difficile non arrendersi a superficialità e materialismo.
Poi arriva Jake, subito dopo un malinconico ritornello cantato da Poopatch.
“Sono il prodotto del freddo di queste strade // Ma in testa ho una corona perché scrivo come voi parlate”
Scrive e rappa di quanto sia difficile essere figli del freddo e delle difficoltà che si sono percorse in una vita, ma che nonostante tutto porti “una corona” in testa, effigie della sua capacità di mettere su carta, di tradurre in pensiero, tutto ciò che comunemente si è solo bravi a dire.
Continua poi, sulla fine della strofa:
“Fra’, chiamaci uomini solo se siamo soli
Quando piangiamo senza nessuno che ci consoli
E’ troppo facile dire che è il mondo che ti esclude
Fra’, hai solo le mani nude ed è così finché si chiude”
Parla di quanto sia difficile soffrire, e di quanto questa sofferenza sia riconosciuta solo nel momento in cui “piangiamo senza nessuno che ci consoli”, quindi solo quando resa privata e non condivisa.
Parla della tossicità del doversi sentire chiamare “uomini”, di quanto il mondo ti schiacci sotto la pretesa di renderti duro.
Le ultime due barre poi, sono un’esortazione al non lasciarsi annegare nel dolore.
È troppo facile prendersela col mondo, un fittizio escamotage per fugare le responsabilità che ognuno di noi ha su sé stesso.
Ci ricorda che effettivamente abbiamo solo le “mani nude”, mani che dobbiamo sporcare se non vogliamo restare stagnati in quel “sorrow”, in quel dolore.
Ora invece ho ventun anni e siamo nel settembre 2022.
È notte tarda e Night Skinny ha appena rilasciato Botox, sua opera ultima.
La tracklist scorre, sonorità che mischiano rap e pop.
Sono un grande fan dei Bnkr44, di Bresh, Tony Effe è in grande spolvero, tutto sommato sono soddisfatto.
Poi leggo il brano che stavo per ascoltare, si intitola “Prodotto”.
Vede dentro Ernia, Paky, Jake La Furia e Lazza.
Ho buone aspettative, “finalmente una bella rappata”, penso.
La canzone inizia.
Quelle note le conosco.
Si sente, quasi in sottofondo
“Sono il prodotto del freddo di queste strade // Ma ho in testa una corona perché scrivo come voi parlate”
La voce è quella di Jake, e il campione della canzone è proprio No More Sorrow.
In un attimo torno ad avere tra i tredici e quattordici anni e mi emoziono, prima ancora che il pezzo inizi.
Ernia, nella prima strofa, rappa come sa fare, Lazza, nell’ultima, ricorda a tutti perché è stato il rapper migliore dell’ultimo anno.
Poi c’è Paky, che è la penna più controversa dei nostri tempi.
Abilissimo nel tirare fuori strofe di un tamarro disumano, ma non dimeno di raccontare il dolore di vite sbagliate – secondo, rispetto all’oggi, solo a Silent Bob.
Paky risulta essere quello che interpreta meglio il brano, riportandoci al mood e alle vibes dei Dogo.
Comincia con “sono il prodotto di asfalto e malavita” e continua poi con:
“Sarebbe tutto bello se avessi una via d’uscita
Ma per quelli come me non esiste un lieto fine
Vuoi fare la guerra a me, ma mi volevi nel tuo EP
E quando, bro, me l’hanno detto, non sapevo manco chi eri
C’ho più problemi di ieri ma meno di domani”
Paky si sente senza via d’uscita, rinchiuso in quel dolore da cui Jake ci esortava a fuggire.
Il suo timbro, tra il masticato e il consumato, si sposa benissimo col sound della traccia e la strofa arriva come un pugno nello stomaco.
Poi c’è Jake, che ha l’accortezza di ricordarci come, per picchi lirici, sia stato indubbiamente il più forte rapper italiano di sempre.
“E dopo tutti questi anni la corona sta sempre su”. Jake non fa nemmeno iniziare la strofa e rivendica subito il suo titolo regio.
Riprende quella corona, posta per la prima volta sul capo ai tempi di Penna Capitale, e si preme di ricordare a tutti che dal suo capo non è mai stata tolta.
Ricorda che lo fa “ancora per voi, non per chi lucra”, e poi chiude la strofa con:
“Sono il prodotto del freddo di queste strade,
E voi siete il prodotto e l’effetto di questa frase”
Jake è e resterà il prodotto di quello che ha vissuto e, consequenzialmente, di quello che ha dimostrato in anni di carriera.
Ma poi ricorda a tutti noi devoti al rap italiano che esiste un’unica verità dalla quale non potremmo mai scappare.
Siamo tutti, inevitabilmente, figli del Dogo.
L’evoluzione che ha avuto il rap è estremamente e nettamente collegata a tutto quello che i Dogo hanno rappresentato e tutt’ora rappresentano.
Il rap di oggi porta ancora l’eredità di quello che è stato, ne è un esempio “Puro Sinaloa”, che vede Ernia, Rkomi, Tedua e Lazza ricalcare le note di quel cult che è “Puro Bogotà”.
Io, mio malgrado, sono un romantico e un nostalgico. Una parte del mio cuore che non accetterà mai il fatto che possano essersi sciolti, perché credo che i Club Dogo sono esattamente quello di cui abbiamo bisogno: un rap crudo, aggressivo, ma soprattutto politico.
In tutti i modi in cui voglia e possa esserlo.
Magari resterà un sogno, probabilmente anche meno.
Ma il Dogo resta immortale, per il semplice fatto che non è mai morto.
Dogofiero.