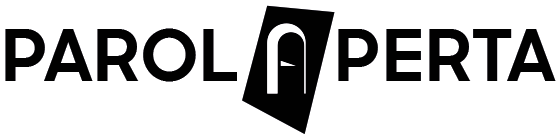“La carne è incompatibile con la carità: l’orgasmo trasformerebbe un santo in lupo.”
E. M. Cioran, “Sillogismi sull’amarezza”, 1952
Nell’attualità della cultura europea, ormai da qualche decennio, il teatro viene sempre più spesso confuso con lo spettacolo e con l’intrattenimento, salvo poche e magistrali eccezioni. “Le Amarezze” di Andrea Adriatico, con il ribaltamento di questo paradigma meschino e imperante, è sicuramente tra queste. Con due date leccesi nel mese di dicembre, lo spettacolo è andato in scena presso i Cantieri Teatrali Koreja.
La stagione delle avanguardie ha affrontato in tutti gli ambiti artistici il problema della crisi dell’individuo inteso quale prodotto della società e della storia. Anche il teatro ha seguito questa urgenza.
Il Novecento ha visto in scena opere e autori ai quali non si può non riconoscere un lavoro di terrorismo culturale, di riscrittura dei modelli e innovazione feroce che ancora oggi costringe ad un mutismo definitivo e ad un pagamento del tributo da parte di chi si voglia precipitare nella cultura segnante: dal futurismo russo, il cui apice drammaturgico si trova sui perigli di alcuni scritti poco noti di Vladimir Majakovskij (come “La Cimice”, Клоп, 1929), a Samuel Beckett e Carmelo Bene.
Nel secolo scorso, tra i cataclismi epocali, in disparte rispetto ai nomi ampiamente impalmati dalla critica, viaggiava anche il dinamitardo francese Bernard-Marie Koltès (1948-1989).
Drammaturgo e regista francese nacque a Metz da una famiglia piccolo-borghese e, dopo una vita violenta, consacrata a desideri di rivolta, morì a soli 41 anni stroncato dall’AIDS, lasciando ai posteri pochi ma notevoli testi teatrali.
“Les Amertumes” fu scritto da Koltès a soli ventidue anni, in quella stessa Francia degli anni ‘70 che nella funesta veggenza di Emil Cioran si dice “una civiltà nata con il mito, poi finita nel dubbio”, quella stessa Francia che meno d’un secolo prima escogitò in Parigi la capitale della modernità e del dolore. In quelle spire già un mutilato d’aureola come Charles Baudelaire bestemmiava all’irrimediabile, contro un culto del progresso che avrebbe torchiato l’uomo metropolitano senza redenzioni, almeno nella vita terrena.
Senza remissione appaiono anche le vicende nell’opera ispiratrice de “Le Amarezze” di Koltès: “Infanzia” (Детство) di Maksim Gor’kij, romanzo autobiografico del 1813 nel quale l’autore fondativo del “realismo socialista”, il cui vero nome fu Aleksej Maksimovič Peškov, ripercorre i nevrastenici eventi dell’infanzia in famiglia, l’educazione religiosa impartita dai nonni, la miseria morale degli zii, la perdita prematura di entrambi i genitori, le vicende offese e le bassezze di vari caratteri che infittiscono questo terreno di “anime morte” e che spingeranno un giovane Aleksej ad adottare lo pseudonimo di Gor’kij, che in russo significa, per l’appunto, “L’amaro”.
L’infanzia travagliata è un luogo ricorrente nella cultura russa: tutti noi ricorderemo, ad esempio, “L’infanzia di Ivan” (Иваново детство, 1962), sbaragliante pellicola diretta da Andrej Tarkovskij su un racconto di Vladimir Bogomolov.
Tornando a Koltès, ho avuto modo di partecipare alla messa in scena delle sue “amarezze” proprio domenica scorsa in uno degli spettacoli della tappa leccese. Ed è la regia di Andrea Adriatico ad aver portato per prima in scena i testi dell’autore francese nel panorama italiano.
Il pubblico viene rudemente scaraventato sul palco, attorno a quello che si presenta come una sorta di tavolo da backgammon cinto da un reticolato. È una scenografia cruda da campo di prigionia o da arena per le lotte clandestine. Sulla tavola ingabbiata, attorno alle recinzioni, si muovono attori in tuta verde, gendarmizzati o detenuti loro stessi, i quali ammoniscono, impartiscono ordini al pubblico, esercitano una coercizione inaspettata, comunicando formule rigorose e autoritarie attraverso distorti microfoni da ring announcer pencolanti dal soffitto.
Il primo dei sedici tableaux che compongono lo spettacolo è una dichiarazione d’intenti sul taglio cinico e asfissiante che caratterizza la regia. Sulle note melliflue di “Atlantide” di Francesco De Gregori si svolge una danza-agonia erotica tra uomo e donna, di rimando ad alcuni espedienti perturbanti di coesistenza tra violenza e musica leggera tipici del cinema “d’exploitation”.
Un attore pronuncia il “manifesto” di Koltès: “Il teatro è gioco. Se si vuole partecipare, occorre conoscerne le regole, accettarle, adattarsi ad esse, altrimenti ci si ritrova nell’inevitabile stupida posizione dell’adulto scaraventato nell’ingranaggio complicato dei giochi dei bambini di cui ignora la trama, e a cui non potrà mai mischiarsi né capirci qualcosa” (torneremo su altri punti del “manifesto” in seguito).
Dunque, per Koltès (come per Bene), il teatro, quando esiste, esiste solo in forma di “infanzia”, ovvero di gioco (“play”, “jouer”, in inglese e francese, si riferiscono ai campi semantici del giocare e della recitazione). Già la fanciullezza, che contiene in embrione l’esperienza adulta, cessa il gioco, apprende la serietà dello scherzo, non partecipa all’atto teatrale.
Questa “Infanzia”, cioè l’unica condizione per il verificarsi del teatro, è la vera protagonista del dramma ed è sempre presente nell’azione sotto la forma scenico-simbolica di una culla, la quale assurge a vascello, ricettacolo, medium tra la coscienza del bambino Alexis (Gor’kij / Koltès / spettatore) e la scena-mondo. Koltès scrive: “…Il personaggio di Alexis si colloca al di fuori dell’azione, poiché l’azione esiste solamente in opposizione ad esso. Ma è grazie a lui che lo spettatore riesce ad entrare nei limiti dell’esperienza…”.
I quadri dello spettacolo si susseguono come caotiche ore d’aria nel cortile-cella sottoponendoci a episodi della vita di Alexis che nella ri-scrittura di Koltès affrontano tutte le tematiche sociali del suo tempo (e del nostro): l’aggressività del costrutto storico di famiglia; la condizione subalterna della donna in società e negli abusi di potere nell’amore; l’omofobia e le discriminazioni; il mediocre sentimento del possesso e le convenzioni borghesi; l’irrazionale ragione dell’odio atavico e della necessità del conflitto.
Senza filtri, aldilà del bene e del male, ne emerge un’umanità brutale, un’affermazione del “Homo homini lupus” di cui lo spettatore può solo prendere atto senza chiavi d’accesso a una soluzione consolatoria.
L’idea di un catastrofismo universale derivato dalla particolarità di un caso è senz’altro favorita dal materiale a monte, ovvero dall’opera di Gor’kij e dalla qualità di certa letteratura russa d’estrarre universi da vite comuni (è questa la forza, ad esempio, di Dostoevskij).
Nell’epilogo assistiamo a una mattanza bellica di corpi nudi e impersonali durante la quale la scena acquisisce una crescente e grottesca conformazione di lager nazista, nell’impotenza completa dell’osservatore che quasi fatica a scindere finzione scenica e realtà (automatico un collegamento ai recenti orrori perpetrati nella Striscia di Gaza).
Ancora nel “manifesto” di Koltès: “…il valore di questo spettacolo sta nell’immediato… e perciò dovrebbe proibire, credo, qualsiasi forma di apprezzamento, sia che l’esperienza abbia avuto luogo oppure no. Oltre a questo, non vale la pena prendere in considerazione nient’altro”.
“Come l’acido sul metallo, come la luce in una stanza buia, le amarezze si sono abbattute su Alex Pechkov”.
(Bernard-Marie Koltès)
“Noi non smettiamo di morire”.
(Battuta ne “Le Amarezze”)
In questa demolizione dei meccanismi scenici e sociali, dunque, allo spettatore non occorre il giudizio, estetico o morale che sia; è, piuttosto, richiesta una capacità di percezione evidente, fino al silenzio, fino a una consapevolezza diretta e purificata dalla dialettica, perciò permeante.
Da ciò si distingue un anarchismo di fondo che denota la natura profondamente politica (in senso assoluto) dello spettacolo, che, in definitiva, ne determina l’efficacia in questo momento storico nel quale le “amarezze” sono quanto mai sotto gli occhi di tutti.
g.g.