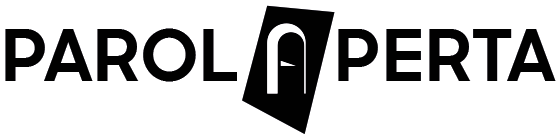è una provocazione, ma continua a leggere

Qualche tempo fa vi abbiamo parlato dei ‘’Neet’’: i giovani che non hanno un impiego, non studiano e
non hanno interesse nel cambiare la loro posizione o, caso contrario, non trovano i mezzi per farlo.
La frustrazione per questa situazione, unita ad una scarsa istruzione e al fatto di crescere in determinati contesti può portare i giovani ad intraprendere la strada del crimine, visto come unico mezzo adatto per sbarcare il lunario.
Quali sono le opportunità offerte per chi ha commesso degli errori e ha intenzione di formarsi?
Vari progetti volti al reinserimento di detenuti posti in semilibertà con la possibilità di intraprendere
una carriera lavorativa.
Il 31.6% dei detenuti è iscritto a un corso scolastico, ma meno del 50% ha ottenuto una promozione. I corsi in carcere si dividono in quelli di primo livello (alfabetizzazione, conseguimento della licenza media inferiore e acquisizione di competenze del primo biennio delle superiori) e in quelli di secondo livello (ammissione al secondo biennio delle superiori, ammissione all’ultimo anno delle superiori e acquisizione del diploma). Sono 1.114 i detenuti iscritti a un corso di laurea, prevalentemente lauree triennali, un dato in crescita rispetto al passato.
Come sostenuto, quindi, l’ordinamento italiano fornisce – o quantomeno ci prova – una serie di
provvedimenti atti a rispettare quello che la nostra Costituzione enuncia con fatica all’articolo 27
comma 3, ovvero ogni pena deve “[…] tendere alla rieducazione del condannato”. Una rieducazione,
nello specifico, che non miri esclusivamente al pentimento e alla reminiscenza del reo, ma che gli
offra la capacità di reinserirsi all’interno del contesto sociale. Per fare ciò, inutile eccedere in
sproloqui, il detenuto ha necessità di allontanarsi da ciò che – il più delle volte – lo ha portato a
delinquere: la disoccupazione. Senza lavoro non vi è retribuzione e, tolta questa, viene meno
l’autonomia e la vita ligia e tranquilla. “Sub lege libertas”, recita un brocardo latino, letteralmente
“sotto la legge, la libertà”: ma come si può rimanere “sotto la legge” se non abbiamo, in questo caso,
quella tanto auspicabile “libertà” economica?
Non è un caso, infatti, se il 68% dei detenuti italiani è marchiato dalla cosiddetta “recidività” (fonte:
DAP, rapporto 2023 del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria), ovverosia l’aver commesso
nuovamente un illecito penale costandogli la misura della reclusione. In sintesi, esci fuori dal carcere
e ci rientri perché hai sbagliato di nuovo.
I motivi di una condotta recidiva sono molteplici e questa non è certo la sede atta ad analizzare ogni
comportamento umano, eppure non può che tenersi in considerazione l’oggettività delle inefficienze
di reinserimento sociale in capo ad ogni latitudine italiana.
Alla base di questa colpevole mancanza, la quale rasenta livelli di illegittimità costituzionale, non può
che rientrare la longa manus economica che attanaglia ogni governo italiano: i tagli. Solo nel 2017,
infatti, il sistema penitenziario ha visto tagliati circa 40 milioni di euro rispetto ai bilanci previsti per il
2016, costituendo una minore possibilità di investimento nella prevenzione e nei sistemi postumi di
reinserimento (fonte: Ragioneria Generale dello Stato). Nel complesso delle spese da sostenere per
l’amministrazione penitenziaria, costola del Ministero della Giustizia, i “trattamenti previdenziali”
costituiscono solo lo 0.2%. più nello specifico, l’80% delle spese sono destinate al personale (forze di
polizia, dirigenti etc), solo l’8.5% ai detenuti.
Insomma, lo Stato poco investe sul futuro di ogni detenuto.
Dall’altro lato della medaglia, si registra come il tasso di recidività sia nettamente inferiore se il
soggetto ha scontato la propria pena secondo misure alternative al carcere: solo il 19% è recidivo,
nonostante non abbia mai visto una cella. Un dato, dunque, atto a farci riflettere finanche sulle
condizioni di vita all’interno delle nostre case circondariali.
A confermare quanto detto, sono alcuni elementi che possiamo ricavare da un report di
www.ristretti.it (http://www.ristretti.it/areestudio/territorio/ali/ricerca.htm) svolto nelle strutture
penitenziarie di Parma. Quasi nella totalità delle fattispecie, infatti, gli ex detenuti sono affidati a delle
associazioni di promozione sociale – e senza fini di lucro – ben radicate sul territorio, le quali
dovrebbero mettere in contatto il soggetto con eventuali professioni compatibili. Similarmente a dei
centri per l’impiego, i risultati sono i medesimi: assunzioni e opportunità a dir poco fittizie.
Da ristretti.it, le problematiche sono chiare e vengono qui esposte – in anonimato – sottoforma di D1
(detenuto 1), D2 e a seguire:
D1: “A Parma hanno solo due educatori per 600 detenuti. Il compito dell’educatore in carcere è quello
di fare un primo colloquio quando entra per la prima volta. E poi dovrebbe seguirli durante gli anni che
devono star dentro. C’è un’equipe composta da criminologi, pedagoghi, educatori e direttore, che
dovrebbe impostare un lavoro di rieducazione per queste persone. Noi sappiamo che ci sono persone
dentro da quattro anni che non hanno mai visto un educatore una sola volta. Questa è una mancanza
del ministero, del DAP. Non assumono e quindi la rieducazione non si fa”
D2: “Il carcere in se stesso per me non è altro che un’università della criminalità. Forse saranno pure
frasi scontate ma io le ho provate sulla mia pelle. Vedo e conosco qualche giovane che è venuto per
una stupidaggine dentro ed è diventato un delinquente.”
Ne figura anche un aspetto psicologico, per il quale in carcere – se ci si accontenta – si ha
tendenzialmente tutto: vestiti, cibo, possibilità di leggere, pregare e compiere qualche attività
ricreativa nelle ore di socialità. Una volta usciti, però, gli stimoli e le esigenze sono ben altri,
parlandone il D3:
“Ci si deve confrontare con la realtà. Qui non hai bisogno di niente, diciamo, o quasi. Se uno si
accontenta. C’è il mangiare, c’è il vestire, c’è questo c’è quell’altro. Invece fuori uno se le deve
conquistare queste cose. E allora se non ha la forza di lottare o di imporsi in determinate cose queste
qui le vengono a mancare. Allora si deve confrontare. Innanzitutto deve sapere lui stesso cosa vuole è
chiaro. Perché se uno dice, domenica prossima esco dal carcere. Alè, io voglio subito una ragazza,
l’appartamento, una bella macchina ecc. ecc. lì non ci siamo mica più.”
Altro fattore determinante, è il tempo: i detenuti, per definizione, trascorrono un quantitativo
considerevole del loro tempo in carcere, rimanendo isolati dal mondo circostante e che si evolve
giorno per giorno. Ne parla il D4, ottenendo un colloquio con un’impresa e dimostrando di possedere
un diploma in ragioneria e di aver lavorato in Fiat. Un CV, così riportato, che potrebbe lasciare degli
spiragli, se non fosse che l’esperienza ottenuta risalga a quarant’anni prima. Ci si ritrova, dunque, con
titoli di studio insufficienti (sono pochissime le strutture che riescono a garantire una formazione
universitaria al detenuto), competenze obsolete ed età fuori dai requisiti odierni, formati da giovani
sempre più giovani, capaci di parlare 8 lingue e da un quadro accademico con almeno due master.
Notiamo, quindi, come nella pratica il sistema di rieducazione italiana faccia acqua da tutte le parti.
Certamente – non ce ne vogliano i rigoristi del diritto penale – il carcere non deve essere un albergo a 5
stelle. E fa anche specie che il popolo, con le proprie tasse, contribuisca alla formazione gratuita per
qualcuno che in precedenza ha “preferito” delinquere. È emotivamente forte, ma il problema sorge
quando la nostra Carta Costituzionale – chiaramente – enuncia le finalità previdenziali dello Stato
italiano nei confronti dei recalcitranti. Contemporaneamente, però, si urla alla necessità di città sicure
e di contenimento dei criminali, senza tener conto che – quantomeno alla base – a questi debba
essere garantita la possibilità di evitare la commissione di reati. Un discorso quasi utopistico e che, se
applicato, rappresenterebbe un Paese da spot Mulino Bianco.
Arrivati a questo punto, provocatoriamente: ha senso il carcere?
Ancora più provocatoriamente: perché non aprire concorsi pubblici a chi ha commesso reati di lieve entità (esclusi concorsi sensibili come forze dell’ordine)?
Resta, insomma, tutto da discutere, con la speranza – per di più – che nel contempo questo governo
non metta mano all’abrogazione del reato di abuso d’ufficio. In tal caso il problema riportato in questo
articolo non si presenterebbe, ottenendo quasi una spoliazione delle carceri italiane. Ma ne parleremo
più avanti.
– Aldo Maria Cupello; Pasquale Spatola