Il cinema, come tutte le arti, è forgiato dalle emozioni. La natura umana si lascia ammirare nei film come nelle canzoni, nei dipinti oppure in un vestito e, puntualmente, lascia senza fiato. Il numero di sensazioni che ho provato vedendo “È stata la mano di Dio”, l’ultimo film di Paolo Sorrentino, è inquantificabile. Il motivo è anche semplice: in quel film ci ho visto me stesso. E in particolare nella prima metà, quando i toni sono ancora disincantati, leggeri – posso dire tipicamente meridionali? – onirici, come solo a Napoli possono essere. Paolo Sorrentino scatta una fotografia a una Napoli che qualche temerario oserebbe definire smarrita. Io non lo credo. Quella era Napoli, ma lo è ancora. È in particolare la mia o la tua infanzia, il nostro habitat, un mondo dai contorni inconfondibilmente italiani, come ritagliati dalla pagina Instagram @ita_pictures. La nostalgia cavalca libera grazie ai ricordi rievocati da “È stata la mano di Dio” e i miei pensieri vanno a mio nonno Luigi, che non c’è più da quando avevo 7 anni, oppure al profumo d’estate rievocato dal film; un profumo agrumato come quello dei limoni di Sorrento che io non ho mai avuto la fortuna di annusare, ma dei quali posso ben immaginare l’essenza, tale è la loro fama.
C’è una figura chiave in “È stata la mano di Dio” ed è Dio in carne e ossa, Diego Armando Maradona. Chi c’era e chi non c’era, tutti sanno che Maradona era fatto della stessa materia dei sogni. Il suo moto perpetuo in campo era lisergico per tutti i comuni mortali che, volenti o nolenti, restavano a bocca aperta dopo un suo goal o una sua giocata. Quando Fabietto, il protagonista, menziona il goal da calcio d’angolo del “Pibe de Oro”, i suoi occhi brillano come un’automobile nuova di fabbrica. Quando si sente la telecronaca del “gol del siglo”, i miei occhi si bagnano improvvisamente, come se avessi assistito a un’apparizione divina. Forse è stato davvero così.
Il calcio è un concetto per me ultraterreno, come tutte le cose in grado di suscitarmi emozioni così forti. La fantasia e la magia portata in campo da certi campioni ha così tanta presa sull’uomo perché, a differenza di tutte le altre cose belle, sappiamo già quando si paleserà di nuovo sotto forma di dribbling o di chissà quale altra invenzione. Non ci sono parole per descrivere un avvenimento come il calcio di Diego Armando Maradona e il film lo comunica con una chiave di lettura direi emblematica: come Dio, la leggenda argentina del Napoli nel film non appare mai, non vediamo il suo volto, non sappiamo chi è realmente. Siamo chiamati inequivocabilmente alla fede.
Fabietto è un diminutivo innocente e gentile, figlio di giovani compagnie, della scuola o delle partite di calcetto a cui apparentemente lui non prende mai parte. Sembra rinunciare a praticare lo stesso gioco del suo idolo, come se non lo sentisse alla sua portata. La sua sensibilità è chiaramente spiccata, i suoi sguardi rivelano un’innata voglia di essere sé stesso, ma la sua vita lo racconta come incatenato a un costume che non riesce a togliersi. Solo in situazioni particolarmente drammatiche o emotive, Fabietto diventa Fabio e sbraita, si agita, si sfoga. Tutte le altre volte, invece, sembra impossibilitato ad abitare il mondo in cui è nato. Se mi specchio, nel mio riflesso vedo i ricci di Fabietto, che sono anche i miei, oppure i suoi occhi bisognosi di qualcosa o qualcuno in particolare, una specie di formula magica in grado di farlo levitare oltre gli usi e i costumi del suo ambiente.
Fabietto, in Patrizia, la zia bellissima che gli ha rubato il cuore, vede tutto quello che vorrebbe: comprensione, amore, ascolto e anche sé stesso, Fabio. Il suo rapporto con lei è speciale e mi piace pensare che ciò sia dovuto anche alla follia di Patrizia stessa, un po’ romanzata, esagitata, forse per questo poco credibile. L’incontro col monaciello ha le parvenze di una visione miracolistica e infatti nessuno crede che sia realmente avvenuto. Nessuno tranne Fabietto, con quell’ingenuità fanciullesca che lascia filtrare, come raggi di sole tra le tapparelle di una finestra, una bontà d’animo molto importante, un’incapacità di pensar male della zia, di non credere alla sua parola. Pende innegabilmente dalle sue labbra, ma non è solo per questo che crede lei abbia ragione, perché altrimenti Fabietto non sarebbe chi è.
Sono contento di vedere che Fabietto abbia visto le stesse cose nel cinema, nel suo più grande sogno, fare il regista e dire qualcosa. Ci è sicuramente riuscito con successo, trasmettendo qualcosa di unico: le emozioni.
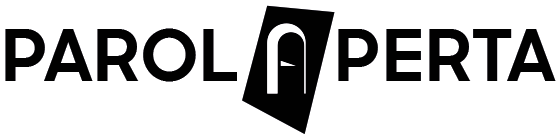




Una risposta
Gran bel film. Finalmente qualcosa che va oltre il suo lato tecnico. Grande PS.