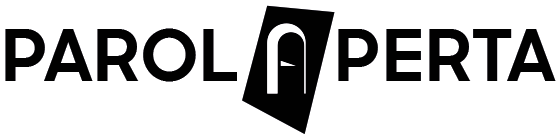tra letteratura e diritti dei detenuti
UN CARCERE A “CINQUE STELLE”
Halden, Norvegia. È qui che risiede “il carcere più umano al mondo”. Come scriveva Dostoevskij in Delitto e Castigo, ed ancor prima Voltaire, “Il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni” e ancora una volta i Paesi del Nord sembrano aver imparato bene la lezione. A guardare le foto di Halden, se non si sapesse che si tratta di un carcere, per di più di massima sicurezza, lo si scambierebbe facilmente per un dormitorio universitario: celle con tv, frigorifero, cucine comuni ben attrezzate con piatti in ceramica, bicchieri di vetro e lunghi coltelli da cucina (legati a un cavo di metallo plastificato), studi di registrazione, percorsi da jogging, campi da basket; il tutto circondato da 50mila metri quadri di foresta tipica del sudest norvegese, un paesaggio composto di cespugli di mirtillo, pini silvestri, felci, muschi e betulle, volto a ricreare un ambiente familiare ad ogni detenuto. Un microcosmo delimitato da un muro perimetrale alto otto metri, simbolo e strumento di punizione, ben visibile da ogni punto della prigione, quasi a ricordare che sì, a Halden è concessa gran parte della libertà nella vita quotidiana, eccetto che la libertà in sé.
Ogni aspetto è studiato attentamente affinché il carcerato fin dal primo giorno della sua detenzione possa, con il supporto delle guardie carcerarie, riabilitarsi socialmente attraverso il lavoro o lo studio, in una condizione che riduce al minimo la pressione psicologica, i conflitti e le tensioni interpersonali. Qui vige quella che viene definita sicurezza dinamica, contrapposta alla più comune sicurezza statica, predominante nella maggior parte delle prigioni di massima sicurezza, in cui il ruolo delle guardie carcerarie è quello di sorvegliare i detenuti per prevenire comportamenti pericolosi, limitando al minimo indispensabile le interazioni. A Halden, le guardie carcerarie – di cui la maggior parte sono donne – non portano armi, fanno attività ricreative insieme ai detenuti per poter interagire con loro e motivarli, e sono avulsi da qualsiasi tipo di metodo coercitivo.
Numerose sono state le critiche rivolte allo stile del carcere, etichettato come “lussuoso” per i suoi mobili in condizioni non fatiscenti, quasi a recriminare che un detenuto sol perché sta scontando una pena non abbia il diritto di essere trattato umanamente, ma da bestia. Tuttavia, se quest’idea non aggrada il nostro animo inquisitorio potremmo pensare più egoisticamente che una buona gestione carceraria è vantaggiosa non solo per i detenuti ma per l’intero Paese: un efficiente processo di riabilitazione sociale dei carcerati non solo promuove la sicurezza dei cittadini, ma porta anche a una riduzione delle spese governative associate a eventuali recidive.
LE CONDIZIONI DELLE CARCERI IN ITALIA
Nonostante per definizione l’istituzione carceraria sia il luogo in cui sanare ingiustizie spesso essa diventa una gabbia in cui ingiustizie vengono commesse. Quella di Halden è una logica atipica anche per la stessa Norvegia, un esemplare che purtroppo non trova suoi duplicati presso gli Stati democratici, nei quali, invece, il trattamento riservato ai detenuti risulta così carente da rendere impossibile una valida rieducazione di questi ultimi. In Italia, solo dall’inizio del 2024 si sono registrati all’interno delle carceri ben 15 suicidi, un dato allarmante che dovrebbe far riflettere sull’evidente condizione drammatica degli istituti penitenziari italiani. A tal proposito, il magistrato Piercamillo Davigo, intervistato su Mani Pulite per il podcast Muschio Selvaggio, dichiara che la mortalità nelle carceri per suicidio è più alta che fuori dalle carceri, per poi aggiungere: “I suicidi in carcere capitano. Dispiace, si perde una possibile fonte di informazione”. A questo punto ci domandiamo se una posizione del genere, priva di umanità e compassione, possa appartenere ad una persona che decide delle vite degli altri. Il suicidio fa parte del gioco, chissenefrega della vita spezzata, semmai è un problema per il magistrato che “perde una fonte”.
Se nel periodo della pandemia da Covid-19 al telegiornale ci veniva detto che era severamente vietato andare a fare jogging in compagnia di un amico, all’aperto, nelle strutture detentive, già da prima affollate, i detenuti non potevano assicurarsi le benché minime misure di distanziamento al fine di ridurre i contatti, e quindi il contagio. Quello della sovrappopolazione delle carceri è un tema che non riguarda solo l’Italia – nel nostro Paese si registra un tasso di 106,49 detenuti ogni 100 posti – bensì tutt’Europa: in ben 7 Stati UE il numero di carcerati supera i posti disponibili. Al problema del sovraffollamento si aggiungono condizioni igienico-sanitarie precarie, pestaggi e mancanza di programmi di riabilitazione efficaci.
UN PROBLEMA INNANZITUTTO CULTURALE
Ora, la soluzione al problema non va sicuramente cercata nella costruzione di nuove strutture o nell’aumento del personale penitenziario, non solo perché queste strategie implicherebbero considerevoli investimenti di tempo e risorse finanziarie – ed il problema è qui e ora – ma soprattutto perché rappresenterebbe una soluzione temporanea e superficiale. È necessario invece affrontare il problema alle radici, e se si scava a fondo si comprende come esso più che logistico sia culturale. Ci si è troppo abituati a vedere da una parte il detenuto come una persona reietta e immeritevole di riscatto e d’altra parte una società che come un banco inquisitorio giudica e punisce senza alcuna concessione. Il radicarsi di questo sentimento in realtà non riflette che un grande fallimento da parte dell’istituzione carceraria e dunque dello Stato, dal momento che viene a decadere il principio enunciato nell’articolo 27 della Costituzione: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. Il carcere dovrebbe rappresentare un luogo in cui espiare la propria pena, in cui riflettere, cambiare, rieducarsi, ricostruirsi, ripartire. Ragnar Kristofferesen, antropologo e insegnante all’Accademia del Sistema Penitenziario norvegese, dove si occupa di formare le guardie carcerarie, spiega loro che trattare i detenuti con umanità è qualcosa che si dovrebbe fare a prescindere, per sé stessi. «A noi piace pensare che trattare i detenuti con gentilezza, con umanità, contribuisca alla loro riabilitazione. Ma ci sono scarse prove scientifiche a sostenere che trattare le persone con gentilezza le dissuaderà dal commettere nuovi crimini”.
I PRIVATI COME PROTAGONISTI DEL CAMBIAMENTO
Il progetto di Halden nasce nel 2010 con un investimento di 250 milioni di dollari: naturalmente non tutti i Paesi posseggono le risorse per adottare un approccio simile nel trattamento dei detenuti, tuttavia, è altrettanto raro che gli stessi siano disposti a trattare i propri carcerati con umanità. Bisogna dunque puntare su soluzioni meno idealiste e più pragmatiche e al contempo perseguibili nel breve termine: certamente una rivisitazione dei testi normativi volta a fornire, a chi di potere, gli strumenti necessari per porre al centro il detenuto in quanto persona, ma in particolar modo, risulta fondamentale un coinvolgimento della comunità nella sua totalità; tutti devono sentirsi protagonisti di questo cambiamento, ingranaggi necessari per il funzionamento di un sistema che riconosce al detenuto la possibilità di un effettivo riscatto, che è poi il fine della pena.
IL CARCERE DI OPERA
Sicuramente le iniziative in Italia non mancano, e ne è un orgoglioso esempio il carcere di Opera, a Milano, che con i suoi 1400 detenuti – la cui quasi totalità sconta condanne definitive – è la struttura detentiva più grande d’Italia. Grazie all’iniziativa de “Il gruppo della trasgressione”, nel mese di novembre 2022 è stata creata un’aula Dostoevskij, dove tutti i mercoledì del mese i detenuti sono stati impegnati nella lettura di Delitto e Castigo. Un romanzo che diventa strumento di riflessione, di invito alla consapevolezza degli sbagli commessi e al conforto di sapere che qualcuno li ascolta: magistrati, educatori, docenti, studenti universitari di giurisprudenza e psicologia, familiari di vittime della criminalità. Riflessioni, dunque, che nascono dai tormenti del giovane Raskol’nikov, attraverso il quale ripercorrere il percorso della trasgressione, del delitto, della coscienza che comincia a risvegliarsi e soprattutto della lenta assunzione della responsabilità del delitto stesso. Raskol’nikov è l’esempio di come nella vita non è mai troppo tardi per riscattarsi, l’importante è desiderarlo, trovare dentro di noi quel moto che ci alimenta, un amore, che nel caso di Raskol’nikov è per Sonjia – donna che lo spinge a confessare il delitto commesso – ma che per ciascuno, altro non è che passione per la vita, ancora e ancora. Dopo più di un anno dall’inizio del progetto, il 25 gennaio 2024 presso il teatro del carcere di Opera si è discusso proprio di opportunità e, a conclusione della serata, Paolo Nori ci ha regalato un’importante riflessione: “Chi di noi non è Raskol’nikov? Io sono Raskol’nikov, Dostoevskij stesso è Raskol’nikov. Lo stesso Dostoevskij è stato un reietto e i suoi migliori libri li ha scritti dopo essere stato dieci anni in carcere.”
Giustizia riparativa e non punitiva, questo è il cambiamento a cui lo Stato italiano deve ambire: il carcere come punto di inizio, e non di fine.