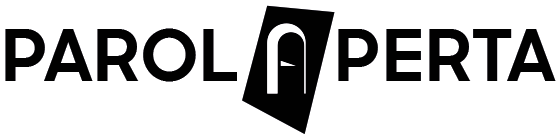Dopo le automobili negli anni Settanta, l’elettronica del consumo negli anni Ottanta, le aziende nipponiche vogliono ora reinventare la famiglia. In Giappone si fanno sempre meno figli, quindi sempre meno nipoti che potranno occuparsi di nonni e bisnonni – come la tradizione vorrebbe. Ed ecco che entrano in gioco i robot, i nostri badanti del futuro.
Tra le società degli automi troviamo, nella “top five”, Giappone, Cina, Stati Uniti, Corea del Sud e Germania.
Il Giappone, al primo posto, è il Paese che registra il numero più alto di vendite di robot. Una condizione favorita dagli aspetti animisti propri della cultura giapponese. Una lunga e vivida tradizione lega infatti le bambole, in giapponese ningyo (letteralmente “forma umana”), all’evoluzione culturale, politica e religiosa del Paese.
Numerose tipologie, ognuna con una sua storia, una sua simbologia, sono tutte custodi di tamashii, vale a dire il gioiello dell’anima appartenente all’artista che le ha realizzate.
Se si considera, dunque, che l’antica religione shintoista – fautrice della dottrina animista – è praticata dall’80% dei giapponesi, è facilmente intuibile che l’investimento nei robot è frutto di una predisposizione culturale, una disinvoltura che vede in queste macchine delle compagne di vita.
In Occidente la percezione è assai diversa, perché alimentata da un immaginario in cui la paura dei robot è profondamente radicata.
Come un tempo si temeva che l’umanità fosse capace di creare cose non in grado poi di controllare – basti pensare a Prometeo, Icaro, il Dottor Frankenstein, trasgressori della volontà divina e perciò vittime di una natura vendicatrice – si temono oggi le nuove macchine.
I neoluddisti hollywoodiani – sceneggiatori televisivi e cinematografici di WGA (Writers Guild of America West) – cercano di difendersi da quest’immaginario distopico: protestano contro l’uso di ChatGPT e reclamano contratti affinché il mestiere dello sceneggiatore resti appannaggio dell’umano. Uno scenario decisamente alla “Black Mirror”. Ma questa è Hollywood, appunto.
Se in Occidente si manifesta quindi contro l’integrazione dell’AI nel mondo culturale e dello spettacolo, in Giappone il teatro è strumento di ricerca nell’ambito della tecnologia robotica.
A testimoniarlo è il “Robot Human Theatre”, un progetto nato a inizio anni 2000 dalla collaborazione tra la Seinendan Theatre Company, Oriza Hirata – drammaturga, regista e accademica giapponese – e il Laboratorio di robotica dell’università di Osaka diretto da Hiroshi Ishiguro, ricercatore e fondatore del ATR (Advanced Telecomunications Research Institute International).
Le Karakuri ningy sono bambole meccaniche, letteralmente karakuri vuol dire “dispositivo meccanico per prendere in giro, ingannare o sorprendere”, un elemento di mistero simile a quello che avvolge il teatro, luogo di inganno tra realtà e finzione, uno specchio attraverso il quale l’uomo può identificarsi, può provare fascinazione come anche repulsione.
Un’aura, questa, che appartiene a bambole e robot quanto più si avvicinano alla complessità di un corpo umano. Una sorta di “immobile dinamismo” attraverso il quale il Giappone mantiene nel suo presente una tradizione del passato. Ravvivandola, aggiornandola, aprendola alla rivoluzione e al cambiamento.
Teatro, antiche bambole, avveniristici androidi. Da qui nasce il progetto “Robot Human Theatre”, in cui l’arte teatrale diventa strumento di studio per l’implementazione di ciò che Masahiro Mori nel 1970 definì “the Uncanny valley”, ovvero la sensazione perturbante che viene provata da un individuo esposto per lungo tempo ad una macchina che replica perfettamente aspetto e comportamento umani. Ed ecco cinque spettacoli sulla società giapponese contemporanea e su un futuro in cui i robot vivranno a stretto contatto con l’uomo.
Il teatro è da sempre il luogo in cui l’uomo guarda a sé stesso, nel doppio ruolo di attore e spettatore, nell’incessabile bisogno di scoprirsi. Ed è per questo che una graduale integrazione di androidi, nella società, deve prima misurarsi con il riconoscimento dei robot come attraenti e non come perturbanti.
Gli androidi devono perciò sembrare umani e non “essere” umani. Queste particolari macchine, sul palco, che non superano le potenzialità degli attori in carne ed ossa, si dichiarano incapaci di provare emozioni.
“No loneliness? or happiness?”, chiede Bryerly in Sayonara, “Androids don’t know”, risponde Geminoid.
Gli androidi assomigliano, quindi, più a delle über-marionetta che a degli attori stanislavskiani. Umanamente, dunque, sono più simili a dei fantocci fedeli alle direttive registiche che a dei personaggi autentici, capaci di ricercare per poi trasmettere la verità emotiva.
Ciò a dimostrazione di come, ad ora, non siano stati sviluppati robot “intelligenti”, capaci dunque di simulare la mente umana. Eppure, negli spettacoli di Hirata il pubblico li percepisce come se potessero pensare o provare emozioni, proprio per il ruolo che ricoprono, di supporto e ascolto all’essere umano.
Lo spettacolo è stato rappresentato, al livello mondiale, in 35 città, suscitando nel pubblico un generale senso di attrazione e coinvolgimento, anche dopo una lunga osservazione dell’androide. Tuttavia l’Occidente si è rivelato meno coinvolto psicologicamente rispetto al Giappone, a riprova della maggiore disposizione culturale del Sol Levante rispetto alla presenza robotica.
Se il robot antropomorfo appare verosimile oggi in un contesto teatrale, ci si chiede se un domani la sua presenza nella quotidianità sarà ben accetta. L’idea, per noi occidentali, appare al momento più fantascientifica che reale.
I risvolti potrebbero assumere caratteri distopici: una macchina che impara a pensare per l’umano, rende l’umano incapace di pensare. O, se non altro, lo rende sempre più pigro nell’esercizio della ragione.
Tutto starà nell’eticità con cui l’uomo farà uso dell’intelligenza artificiale.
Già nel 1950, Alan Turing, uno dei pionieri dell’AI, dichiarò che “l’intelligenza, come la bellezza, è negli occhi di chi guarda”. Un invito all’uso di quel “difetto” di cui Bertolt Brecht ci parla nella sua poesia “Generale, il tuo carro armato”.
Il difetto della facoltà di pensiero, che ci preserva dalla manipolazione e ci distingue dalla macchina.