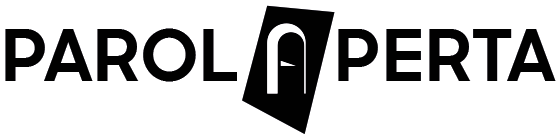Il pomeriggio in cui conobbi Agnes era crudelmente arido.
Era l’agosto dei miei dieci anni. Nella mia impressione del tempo, quel mese aveva l’effigie di solo mare: la scuola, in agosto, conservava l’aspetto di un approdo lontano, poco minaccioso, ancora allegramente indegno d’afflizioni. Mi davo perennemente all’acqua, ore di onde senza flemma, sino a quando i polpastrelli raggrumati non avessero sancito la cittadinanza acquatica.
Ecco perché l’incursione nel mio svago di una sconosciuta insegnante madrelingua inglese, che avrebbe
dovuto accompagnare il mio percorso durante l’intero anno scolastico (e, perché no, se avesse incontrato l’approvazione mia e di mia madre, anche negli anni a venire), fu gran schiaffo alla leggerezza vacanziera.
Fu proprio mia madre a cercare l’insegnante per me, scavalcando ogni automatismo espresso da tutti i
genitori dei miei compagni d’iscrivere i figli ai corsi di lingue in istituti specifici, per il doposcuola, fregiati
dell’insegna della Union Jack e di cartelloni vividi di proiezioni di futuro a Oxford e a Cambridge.
Mia madre aveva invece l’impressione che, se mai avesse sancito anche per me quella via, io avrei visto
trascolorare i miei pomeriggi in assillo accademico, grigie parentesi di due o pure tre ore al giorno, ben tre volte a settimana, sospettosamente pseudo scolastiche, centrate molto più sull’obiettivo di esami da superare entro giugno che sulla prassi dell’inglese. Dovetti riconoscere che mia madre mi stesse salvando: lei credeva molto più nell’idea che imparassi a padroneggiare in scioltezza l’idioma che agli attestati e alle certificazioni.
Così, trovò Agnes Grad, nel trafiletto dell’Unione Sarda: “offresi insegnante madrelingua inglese a
domicilio”.
A dirla tutta, non m’ispirava quel nome marmoreo, Agnes, con la “g” da pronunciare dura, senza possibilità di alleviarla nella consonanza con la “n” che seguiva.
Al tempo stesso, c’erano in me le sentinelle di un’astratta aspettativa, che mi afferrava lo sterno, uno sprone involontario alla lucidità, come in affaccio su un esame incombente: in modo del tutto incorporeo, quasi presentissi l’idea che la signora in arrivo avrebbe incarnato un contrassegno.
Ecco perché, assillata da improvvisi scrupoli, cercai di estendere una dignitosa perizia in vista del primo
incontro con Agnes, persino nel disporre l’indispensabile sul tavolo circolare nel gazebo del mio giardino di casa, a picco sul mare vivo, sotto il faro di Calamosca a Cagliari. Recuperai un quaderno stinto: non pensavo che l’occasione meritasse il sacrificio di un quaderno fiammante. Ci appioppai accanto una penna verde quasi esaurita che sembrava potermi tradire da un momento all’altro, accanto a una matita invece impeccabile, dalla punta ritta, così perfetta che avrei voluto preservarne la grafite dall’usura.
Il tempo dell’attesa fu inappuntabile.
Finalmente, la vidi. L’imponente figura diede cenno della propria indole anche solo per via del modo in cui si annunciò, l’urto deciso con cui sigillò alle proprie spalle il cancello d’ingresso del giardino di casa mia, che mia madre aveva provvidenzialmente lasciato aperto.
Quel giorno, Agnes portava i capelli in un groviglio incerto, una pinza a uncinare una treccia precaria,
arpionata alla testa in un nodo per metà decolorato. Indossava una maglietta azzurro fiordaliso, del tutto
priva d’orpelli; le comprimeva le forti, munifiche linee del corpo. Le sue gambe mi parvero solide, rabbiose e ansanti, mentre la fronte umida, rorida di fatica, era chiaro manifesto del suo tragitto, percorso a passo intenso. Sapevo vagamente che Agnes abitasse a una consistente quarantina di minuti da casa mia: intimamente, trovai ammirevole e folle l’idea di affrontare una strada del genere interamente a piedi sotto dardi del sole agostano.
Quando però lei sedette al tavolo del gazebo, mi comparve agli occhi un’immagine formidabile, capace di scardinare l’impressione massiccia, di colpo smentita dalla levigata perfezione delle mani di Agnes,
impeccabili ambasciatrici dei suoi giovani trentacinque anni. Neppure un nodo alle giunture. Giammai ombre livide di danza vascolare. Ancorché non affusolate, tutto, in quelle mani, dita, dorso, palmi, persino le unghie, conchiglie in perla, suggeriva cura e freschezza. Quando gliele strinsi, seppi che erano davvero lisce e salde come suggeriva il loro aspetto. Se le sue apparivano quiete e indecifrate quanto l’espressione sul suo viso, le mie, in quel momento, balbettavano.
Quel pomeriggio, Agnes non giudicò la penuria di pagine del quaderno, ignorò la penna verde e fece subito razzia dell’intatta matita. Non fu affatto impressionata dalla mia preparazione, cosa che davvero sminò il mio entusiasmo. Ma se fronteggiare la piattezza di reazione fu piuttosto frustrante, in realtà quella lezione d’esordio non fu che il primo, fondante segno dello squarcio del guscio di formalità che avrebbe caratterizzato i primi mesi del nostro relazionarci.
Così, gli anni sotto la sua vigile sovrintendenza divennero sei.
I momenti di lezione con Agnes si ripetevano il lunedì e il venerdì, due ore per ogni incontro. Non che fosse facile, per me, proporre rinnovato ardore tutte le volte. Mi stizziva, quando lei gridava, con venti minuti in anticipo rispetto all’orario stabilito, quel suo “Buongionoooh!”, un’esclamazione acuta e gutturale, congiunta alla familiare eco del cancello sbattuto, quando io ancora trascinavo le lunghe fatiche di cinque ore di scuola appena trascorse. E mi sfuggivano poi certe posture torve, di fronte al pertinace somministrarmi i suoi estenuanti test, test, e ancora test, vocabulary, writing, listening, speaking, sui quali Agnes accampava inflessibili attese, senza concedere mai un accenno di suggerimento, nel segno della perenne esortazione a un impegno maggiorato.
C’erano giorni in cui semplicemente Agnes, con uno sguardo dolente, si rintanava in laboriosi silenzi, nei
quali avvertivo una cupezza profonda, persino insondabile, che lei troncava giusto per assegnarmi lunghi elaborati da scrivere “write, Angelica, come on, don’t bother me for a couple of minutes”, in modo da non turbarla in quelle sue parentesi che imparai a riconoscere come intoccabili.
Al tempo stesso, presto presi coscienza del fatto che Agnes avesse assunto per me la fisionomia d’indagine umana, da condurre con amore e tenerezza: temperavo le domande, aguzzavo le idee nel tentativo di raggiungerla, di accedere alle porte del suo essere, nelle costellazioni dei suoi affetti, nelle maglie del suo passato. Scoprii che Agnes era di madre londinese, dunque perfettamente anglofona, ma quando scrutai nell’accento intensivo, genuinamente rude e marziale, seppi che scontava un diverso retaggio antropologico: l’altro ramo familiare e il luogo natio erano viennesi. Inesorabilmente teutonici, come lei.
Piano piano, negli anni, Agnes cominciò a scucire qualche istinto. Un giorno mi affidava una piccola
confidenza, un altro tendeva in mio favore una lode spassionata, e un’altra volta ancora un’inattesa, titubante carezza sul capo.
Un pomeriggio del mio quarto anno con Agnes, Cagliari cadde vittima di un leggendario temporale. Viluppi argentei e neri si azzuffavano come centauri, sospinti da un vento, scuro e persino visibile anch’esso, tanto era soverchiante sino all’apnea; sul mare di casa mia incombeva un senso di terrore.
Quel giorno, per la prima volta, Agnes sbucò dal sedile passeggero di un’auto, che dedussi essere quella del marito. Mentre mi affannavo ad accoglierla con urgenza, l’ombrello schiuso e una fibrillazione atterrita e premurosa, a volerla trarre in salvo da quella minaccia meteorologica, ebbi un’istantanea d’incongruenza.
Notai qualcosa di volubile nel modo insolitamente mite in cui lei sillabò “thank you, thank you, Angelica”,
un sospiro assente. Di norma generalessa ferrea, quel giorno Agnes tintinnava le gambe, in
un’inconsapevolezza motoria apparentemente irrefrenabile. La macchina, intanto, si era allontanata con una retromarcia brusca.
Una volta entrambe al sicuro, nel loggiato vetrato in cui facevamo lezione nei mesi invernali, Agnes
ricompose il tremore. Tentò di rabberciare l’espressione malferma, che le il viso in allarme: si passò due dita sotto gli occhi, come per raddrizzarli, ed esibì il ventaglio di denti in un sorriso pronto, diligente, non suo.
Mi diede frettolosamente da fare alcuni esercizi grammaticali, curiosamente dimentica di avermeli già
assegnati la volta precedente, e si voltò verso il finestrone che dava sul pieno della bufera. Pian piano, librò lo sguardo, e i suoi occhi si fecero stellanti di meraviglia; era avvinta dal primitivo clangore, come se non avesse mai assistito a uno spettacolo simile. Presto anch’io, come lei, mi trovai assorta, ma la mia
concentrazione prese a focalizzarsi solo su di lei.
Perché fu davvero allora che riuscii a vedere Agnes, a vederla sul serio, per la prima volta.
Nell’inconscio tentativo di districare i capelli, zuppi di pioggia, svelò un orecchio violaceo e un po’ gonfio, la contusione che si allargava anche sullo zigomo.
Quella vista fu un tumulto. L’istinto mi suggerì la tempestività di una reazione, le domande, subito,
impellenti, protettive, saettanti “cos’è successo? Chi te lo ha fatto?”, assieme al fiorire repentino di un oscuro sospetto, che molto aveva a che vedere con la macchina che eccezionalmente l’aveva accompagnata solo quel giorno in quattro anni di quotidianità praticata con me, con i giorni in cui Agnes si trincerava nel mutismo, con la reticenza sorvegliata che riservava al racconto di pezzi di vita familiare.
Ma lasciai che discrezione sbaragliasse il mio incauto vigore. Non parlai.
Al tempo stesso, mentre contemplavo quel marchio sul viso della mia Agnes, vissi un’intrusione un po’
proibita e irreversibile, epocale, pari solo a quella della volta in cui vidi volar via il velo di suor Maria Paola, la mia giovane, paffuta e paziente catechista, impietosamente spazzato via da una buriana, a svelare il capo nudo, i suoi scioccanti capelli alla maschietta.
Ecco, anche nei capelli liberi di Agnes, sciolti sulle spalle come un mantello fradicio, c’era qualcosa di
decisivo: vidi un mondo d’insospettabile femminilità, di colpo dolce – lei che dolce, con me, lo era stata solo a gocce. Si pettinò le ciocche umide con fare incurante: fu allora che un appello razionale mi suggerì che Agnes avesse slegato la sua sgangherata acconciatura forse per attutire la viscida sensazione di tutta l’acqua piovana che le appesantiva i capelli. Così le chiesi prima se gradisse un asciugamano e poi, nel trasporto di una sollecitudine ulteriore, un phon e un caffè. Agnes oppose inizialmente un prevedibilissimo rifiuto; mi accorsi subito che fosse un diniego di quelli cedevoli, sui quali un’insistenza gentile avrebbe sortito un’efficacia. E infatti, dopo qualche minuto di mia accorata persuasione, Agnes accettò il phon. Soltanto il phon. Lo accolse con un grazie smunto accompagnato da un sorriso che era una finestra aperta su tutta la sua gratitudine, molto più eloquente di un suo ipotetico (e, a dirla tutta, impensabile) alzarsi e fasciarmi in un abbraccio. Si asciugò la chioma con consueta distrazione, serbando ancora il sorriso. Infine, tornò alla lezione. Da quel pomeriggio, però, seppi che in lei si fosse schiuso il mutamento, dopo il quale non fu mai più la stessa. Un trionfo: l’intesa era sancita e, ne ero certa, non sarebbe mai più dissolta.
Mi sbagliavo.
In un assolato 19 maggio, Agnes prese commiato, per non fare più ritorno.
Quel nostro ultimo giorno insieme, cinse la lezione in una mezz’ora che volò. Prima di dileguare per sempre, sostò un attimo sulla soglia, tra il giardino di casa mia e la strada fuori dal cancello d’ingresso; in un impeto senza preamboli mi regalò il suo paio di occhiali da sole che tanto spesso le avevo visto addosso, a schermarle il viso, anche nei giorni in cui il sole dismetteva i doveri.
Era un’analfabeta sentimentale. Lei non aveva altri strumenti per tradurre le carezze che non era in grado di darmi. E io ancora non sapevo che quegli occhiali avrebbero assunto per me il pregio di reliquia.
Agnes non volle, o forse non poté raccontarmi l’imminenza dello strappo. L’addio. La fine.
Non avrebbe più risposto a nessun messaggio. Avrebbe disattivato il suo indirizzo mail. Non avrebbe mai più cercato il ponte di un contatto. E aveva ben provveduto, prudenzialmente, affinché nessun segnale fosse disseminato per farsi trovare: lei lo sapeva. Io, no.
Agnes sparì per sempre.
Forse era riuscita a salvarsi.